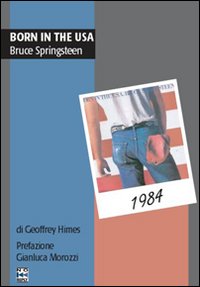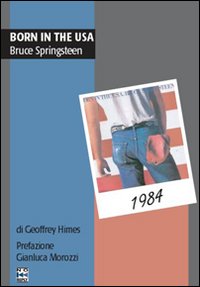
Geoffrey Himes “Born in the U.S.A.”
Questo agevole libricino è molto più prezioso della gran parte dei tomi che periodicamente vengono pubblicati sull’arte di Springsteen. E’ vero, tutta l’attenzione è concentrata su un solo disco – come nei piani della nuovissima collana Tracks inaugurata proprio con questo volume dai tipi di No Reply – ma l’autore Geoffrey Himes è bravo a contestualizzare “Born in the U.S.A.” senza circoscriverlo agli anni in cui fu concepito e realizzato, cioè i primi anni Ottanta. Il percorso che porta nel 1984 il trentaquattrenne Springsteen a pubblicare “Born in the U.S.A.” parte da lontano, dall’adolescenza tutt’altro che tranquilla in cui finì preda del demone del rock’n’roll. Con approccio genuino e senza la smania completista di tanti aficionados del Boss, Himes sostiene una tesi più o meno condivisibile – che “Born in the U.S.A.” cioè sia il miglior album di Springsteen – bandendo la retorica e trattando le canzoni col rispetto che meritano, mescolando aneddotica e perle di sociologia ribelle («nato all’ombra di una bomba atomica che ha fatto sembrare grottesca l’idea di una gratificazione procrastinata, il rock’n’roll ha promesso ai suoi ascoltatori che avrebbero potuto avere tutto e subito»). Springsteen, nei primi anni della sua carriera, era stato fulgido paladino di tale utopia rock; col tempo, però, aveva capito come la realtà dei fatti fosse drammaticamente diversa e, se pure esisteva una qualche terra promessa, erano in pochi ad avere la possibilità di raggiungerla. Nell’accezione springsteeniana, l’utopia del rock’n’roll sottintedeva che la terra promessa spettasse a tutti nessuno escluso. La disillusione generata da tali sogni giovani tramutatisi in chiacchiere portò alle tinte fosche di “Darkness on the Edge of Town”, ad alcuni episodi di “The River” e alle riflessioni solitarie di “Nebraska”. Infine a “Born in the U.S.A.” e a quella pietas verso i reduci del Vietnam, per Springsteen «gli esempi più tragici di tutte le persone abbandonate dal sogno americano e dalla promessa del rock’n’roll».
Nelle quasi duecento pagine del libro scopriamo come sono nate le grandi canzoni contenute nell’album, dalla prodigiosa title track («sembrava un inno, era un atto d’accusa») alla profonda My Hometown, dalla sensuale I’m On Fire a Dancing in the Dark, il «tentativo più riuscito di Springsteen di creare un sound R&B moderno».
Terminato il libro, che lo springsteeniano non riuscirà a non leggere tutto filato dall’inizio alla fine, si prende dallo scaffale il cd di “Born in the U.S.A.”, lo si inserisce nel lettore e si preme play. L’accordo al piano di Danny Federici, il rullante riverberato di Max Weinberg, il riff di sei note all’organo di Roy Bittan. Nato nella città dell’uomo morto, il primo calcio lo presi appena misi piede a terra, come un cane picchiato troppo a lungo finisci col passare metà della tua vita nascondendoti, nato negli U.S.A. …
|